Il film tratto da Burroughs è uno scontro tra codici generazionali, iniziando dal nome, dalla sua traduzione in italiano e finendo a Jean Genet e Harry Styles.
Mentre vedevo QUEER in lingua originale mi sono chiesto come sarà tradotto il suddetto termine più volte ripetuto nel doppiaggio italiano del film che uscirà a febbraio. Non è questione da poco, l’adattamento non è mai traduzione pura, è sempre interpretazione in cui tantissime discipline convergono per una soluzione più aderente possibile a quella della matrice. Sarà “frocio”? “Gay”? O avranno filologicamente e appropriatamente utilizzato “checca” come la prima traduzione dell’edizione italiana Adelphi del 1998?
Dico appropriatamente perché benché manchevole di qualche sfumatura, è una scelta che storicamente è maturata nel momento più appropriato a restituire le reali intenzioni.

Nel caso della parola “queer” non solo siamo di fronte a un termine con una mancanza di corrispettivo italiano che ne riproduca la sua storicità e approccio epistemico (il libro è scritto agli inizi degli anni ’50), ma anche a un neologismo semantico che col tempo e con l’avvicendarsi delle ultime generazioni ha mutato forme diventando sfuggente (come deve essere per i concetti agenti evoluzioni e rivoluzioni).

Mi capita spesso di esser criticato perché il mio nickname digitale non rispecchi le aspettative di alcunə sul concetto di “queer” (sul “geek” per fortuna c’è ancora una certa tranquillità, ma non diamo spunti).
La questione è che la mia espressione di genere sia percepita molto maschile in coerenza a un’identità cisgenere ben definita, con buona pace di Judith Butler quando diceva che il genere è un tipo di imitazione di cui non esiste l’originale.
Senza entrar nel merito di una mia risposta, mi interessa la scala di percezione del “queer” che indubbiamente negli ultimi vent’anni ha coinvolto maggiormente l’identità e l’espressione di genere, diventando -questa la parte più interessante- antitetica all’utilizzo che storicamente ne ha fatto la comunità LGBTQIA+ fino a poco prima.
“Queer” nell’educazione politica e culturale di chi è cresciut* negli anni ’80 e ’90 era sinonimo di “frocio” in quella riappropriazione terminologica delle minoranze di svuotare della violenza insulti e parole degradanti per assorbirli, rimasticarli, addomesticarli e riutilizzarli depotenziati, in un riciclo semantico che esorcizza e rivoluziona (ne ho parlato lungamente qui).
Queer, come frocio, sono parole fortemente politiche. La mia militanza politica LGBTQIA+ è nata al Cassero di Bologna, già Circolo 28 Giugno nel 1979, già Collettivo FROCIALISTA nel 1977.
“Add your name to this hall of fame
The answer is clear
They´re All Of Them Queer
Add your name to this hall of fame
Stand up and cheer
They´re All Of Them Queer”.
Lo cantava Holly Johnson nel 1995, anno del mio coming out, fornendomi non soltanto un inno ma una guida didattica, delle istruzioni didascaliche su quali dovessero essere le mie basi culturali di identità politica queer: Andy Warhol, Johnny Ray, William Burroughs, Jean Genet, Isherwood, Wilde, Capote, Auden, Jean Cocteau, Joe Orton…
In anni in cui quindicenne ero l’unico omosessuale sulla faccia della terra, o almeno nel Molise, senza internet e tantomeno qualsivoglia associazione, mi ritrovai a divorare la bibliografia, filmografia o biografia di ogni singolo nome che snocciolava l’ex cantante dei Frankies Goes To Hollywood.
“Queer” era sì “frocio”, ma “frocio politicizzato”, con orgoglio e sfrontatezza di chi conosce la valenza storica, da Michelangelo a Divine, da Cole Porter a Derek Jarman, passando per Candy Darling.
Lo dice bene Holly: sono tutt* queer.
Ma indubbiamente queer è diventato altro, aggregandosi a identità di genere volutamente non definite, e poi via via ad azioni che sfuggono i confini, fino a errate interpretazioni prive di studio e prospettive storiche che si sono infilate in young adult o sotto le scarpe di Harry Styles (forse mi è uscita acida ma non vuole esserlo).
Guadagnino si impone in un momento storico perfetto per riportare il discorso sulle origini e i significati storici della parola e quel “Queer” del titolo definisce già una cittadinanza culturale, quella pre-globale, pre-internet, pre-2000, stilando un codice identitario generazionale fatto di luoghi, azioni, sentimenti, situazioni, linguaggi e inserendoli nella tradizione letteraria, cinematografica e artistica tout-court, fondante della comunità gay dell’ultimo secolo.
Il libro di Burroughs nasce già impossibile da mettere in scena se non appunto facendolo proprio, masticandolo e vomitandolo come un cuore nella membrana sotto ayahuasca. L’unico modo per darne forma cinematografica era farlo proprio, e da lì parte il regista per stilare un compendio, un codice della propria educazione politica e culturale, prescindendo dal testo originale ma restando fedele al suo invito di autodafé dei corpi.

Il Codice Guadagnino è un codice ostico per i ventenni e i trentenni LGBTQIA+ ma necessario da studiare e comprendere per poi contaminarlo con il contemporaneo, per ritrovare un punto fermo in questa ipercinetica guerra di contenuti frammentati e scollegati.
L’abbordaggio nei vicoli, la rete di locali notturni, parole segrete, parole d’ordine e parole chiave si contrappongono a nuove reti digitali e social di app di dating; così come la ricostruzione di Città del Messico diventa messinscena di un luogo che esiste solo come scenografia di un movimento psichico, di una ricerca all’autodeterminazione.
Il codice suggerisce costantemente il Querelle the Brest di Fassbinder e indiretto il libro di Jean Genet (e gli echi di Notre-Dame-des-Fleurs) e via fino a Pasolini, ai surrealisti di Magritte , a Bill Viola e al tanztheater sotto acido. Mai nulla è solo estetica, tutto è rielaborazione.
La droga è presente come botola di fuga ma anche come porta rivelatrice, strumento sovversivo dell’essere e non solo dell’azione, dove la verità si frantuma moltiplicando i significati. Persino la musica scelta da Guadagnino ci ricorda quanto autodistruttivo e pericoloso sia il perdersi nella ricerca, infilando in sequenza nella colonna sonora tre musicisti dissolti nelle drammatiche ombre personali: Sinéad O’Connor, Kurt Cobain e Prince.
È prezioso il Queer di Guadagnino perché oggi più che mai abbiamo bisogno di riappropriarci di una parola fondamentale e perché, dopo aver raccontato i giovani e le loro relazioni in Challengers o Bones and All, riporta il discorso dei corpi di soglia nella prospettiva storica (forse personale? chissene, è universale comunque).
Quello che verrà e cosa diventerà il “queer” decidiamolo insieme ma partiamo da qui, da questo punto, senza dimenticare cosa è stato, altrimenti rischiamo di perdere due cose fondamentali: tempo e la nostra cultura comunitaria.
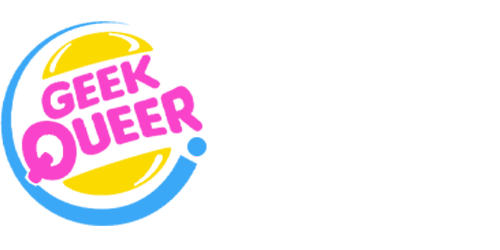
sx1l82
s7syw1
lrw2ii
2o6fw9